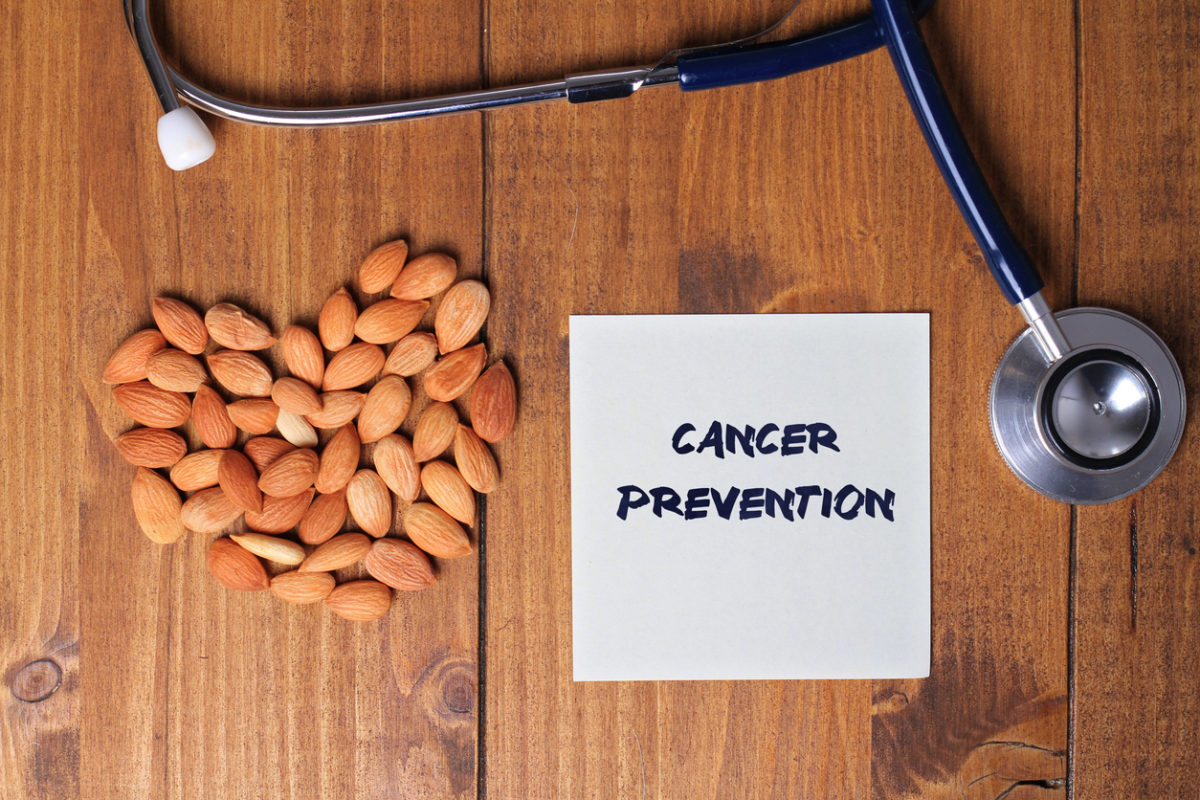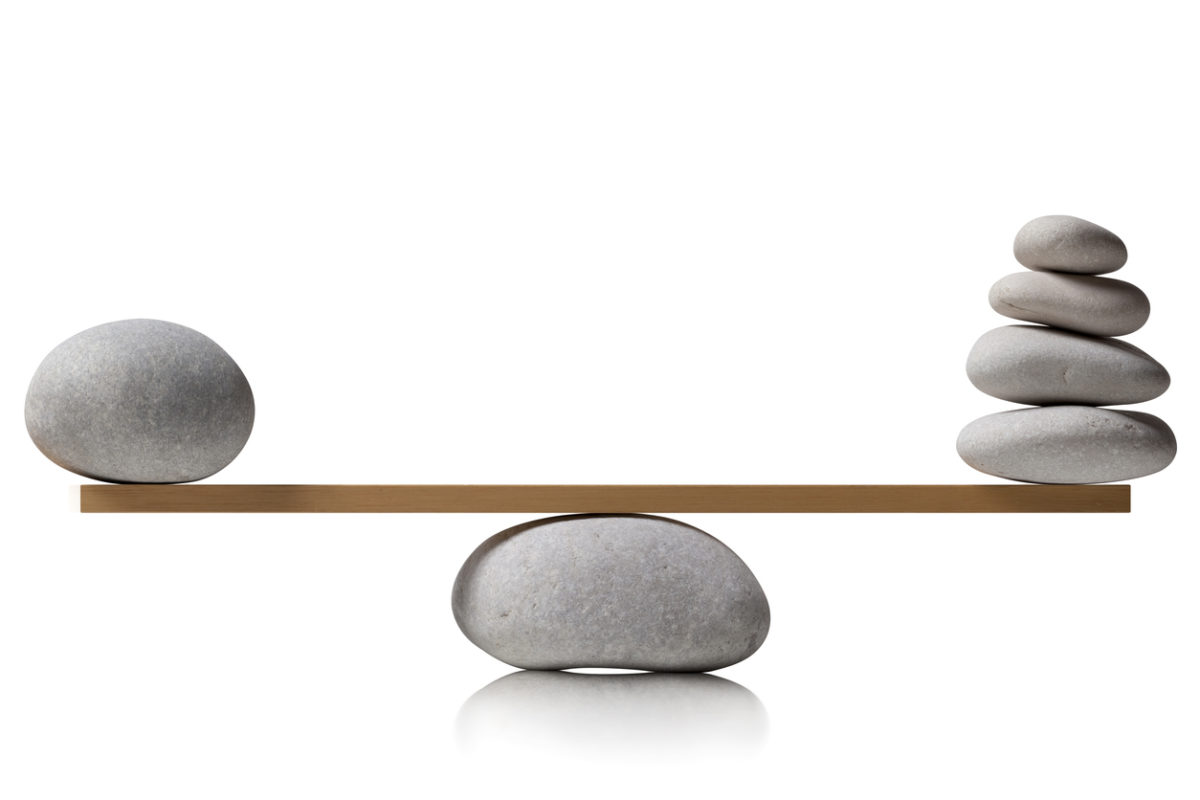Un fenomeno in crescita
Da alcuni decenni i paesi industrializzati registrano un’inarrestabile dilagare del sovrappeso e dell’obesità. Il trend riguarda anche alcuni tra i più piccoli che si trovano a fare i conti con un patrimonio genetico votato al risparmio energetico ed uno stile di vita profondamente modificatosi negli ultimi vent’anni: giornate infarcite di tecnologia e cibo che lasciano poco spazio al movimento spontaneo e ai giochi, accudimento talvolta carente rimpiazzato da cibo e televisione, comportamenti alimentari familiari alterati e molto altro portano a un risultato sempre più allarmante, anche all’interno del territorio italiano.
I dati ISTAT evidenziano livelli preoccupanti di eccesso ponderale nei ragazzi tra i 6 e i 17 anni: il 22,9% dei soggetti misurati è risultato in sovrappeso e l’11,1% in condizioni di obesità.
Si evidenzia, inoltre, una spiccata variabilità interregionale , con percentuali tendenzialmente più basse nell’Italia settentrionale e più alte nel Sud (dal 15% di sovrappeso e obesità nella Provincia Autonoma di Bolzano al 48% in Campania).
Più di 1 bambino su 3, dunque, ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. Riportando questi valori a tutta la popolazione di bambini di età 6-11 anni si arriva a una stima di più di 1 milione di bambini in sovrappeso od obesi in Italia.
All’allarme globale lanciato dalle società medico-scientifiche fanno seguito programmi di prevenzione su larga scala. La terapia, invece, rimane di difficile definizione.
Le cause
L’obesità infantile, fenomeno alquanto diffuso, è il risultato di diverse cause più o meno evidenti che interagiscono tra loro. In primo luogo le responsabilità ruotano intorno a una eccessiva o cattiva alimentazione, una ridotta attività fisica e a fattori di tipo genetico-famigliare.
Si parla dunque di un’eziologia multifattoriale che chiama in causa alimentazione, sedentarietà, fattori genetici e fattori ambientali. L’avere uno o entrambi i genitori obesi è il fattore di rischio più importante per la comparsa dell’obesità in un bambino.
Un altro fattore da tenere in considerazione è la precocità dell'”adiposy rebound”: normalmente dopo l’età di un anno, i valori di IMC (Indice di Massa Corporea: peso in kg /altezza in m2) diminuiscono fino a raggiungere il valore minimo attorno ai 5-6 anni per poi riprendere ad aumentare. Un incremento dei valori di BMI prima dei 5 anni (adiposity rebound precoce) viene riconosciuto come un indicatore precoce di rischio di sviluppo di obesità.
Negli ultimi anni la ricerca ha portato alla luce il contributo genetico della familiarità nello sviluppo dell’obesità. Studi su gemelli omozigoti e soggetti adottati, attraverso la correlazione del peso dei soggetti stessi e dei genitori adottivi e naturali, hanno dimostrato che il grado di ereditabilità del sovrappeso varia dal 60 al 70%; osservando le famiglie dei bambini obesi si è visto quindi che avere uno o entrambi i genitori obesi aumenta la probabilità di essere obesi.
Ma l’aumento così repentino del numero di bambini obesi non può esser imputato solo alla predisposizione genetica: non possono infatti essere mutati così drasticamente i caratteri genetici in un intervallo di tempo di qualche decennio.
Uno studio condotto su gemelli nati dal 1975 al 1979 in Finlandia dimostra che il BMI è strettamente correlato al peso alla nascita e al BMI dei genitori. Il periodo intrauterino ha dunque effetti durevoli sul peso corporeo adulto. Alcuni studi epidemiologici suggeriscono l’esistenza di un legame tra sviluppo di obesità in età evolutiva e allattamento al seno: bambini allattati al seno mostrano un rischio più basso di essere in sovrappeso da adulti e adolescenti in modo proporzionale alla durata dell’allattamento.
Il patrimonio genetico è la base su cui si estrinsecano altri fattori: alimentazione, inattività, contesto sociale, comportamento alimentare. Tra i diversi aspetti dell’alimentazione si sta cercando di capire quali contribuiscano in modo particolare all’eccesso ponderale.
Una panoramica
I bambini nascono con una capacità di autoregolazione precisa ed efficiente.
Sete, fame, sazietà e molti altri bisogni sono controllati nell’organismo animale con sofisticati meccanismi che garantiscono un equilibrio.
Perché in natura gli animali mantengono costante il loro peso? La risposta è nelle capacità di riconoscere i propri bisogni e di dare loro una risposta adeguata, funzione compromessa nell’uomo da condizionamenti esterni, dalle abitudini familiari, dalle regole della società, ecc…
E’ frequente riscontrare nell’obesità un’alterazione dei meccanismi autoregolatori. L’assunzione di cibo non è motivata solo dalla fame: si mangia perché è l’ora del pasto, perché è un modo di stare in compagnia, perché uno stato emotivo trova nel cibo una momentanea gratificazione o al contrario non si mangia perché non c’è tempo, perché si segue una dieta, ecc.
Se questa è una delle cause, è anche una delle risposte.
Riscoprire fame e sazietà, distinguere la fame biologica dalla fame emotiva, concedere tempo e attenzione al pasto, gustare e non divorare, ritrovare dunque un rapporto equilibrato con il cibo, fonte di sostentamento ma anche espressione di tradizioni, simbolo di cultura e manifestazione della propria personalità.
Sostenitori di questo percorso di cambiamento nei bambini e nei ragazzi sono i genitori ed i familiari, che hanno il compito di fare la spesa, organizzare la dispensa, programmare pasti equilibrati ed aiutare il bambino nella comprensione dei suoi bisogni e nella ricerca della risposta migliore.
Il bambino o l’adolescente fanno parte di un sistema-famiglia, di un sistema-scuola, di un sistema sociale in senso lato (mass media e pubblicità, consuetudini culturali) che influenza fortemente le scelte e le abitudini di quel soggetto anche in campo alimentare.
Aspetto importante nella prevenzione e cura dell’obesità è anche l’attività motoria: il movimento, indipendentemente dallo stato di salute, è una necessità fisiologica per qualsiasi bambino.
È ugualmente importante che l’essere nutrito, pulito, accudito; in definitiva è parte integrante del suo processo di sviluppo, inteso nel senso più ampio del termine. Il movimento favorisce una crescita corporea armonica, fisica e psicologica, aumenta l’agilità e la forza e di conseguenza migliora l’autostima e il senso di benessere, favorisce l’apprendimento e riduce l’ansia per la prestazione scolastica, favorisce la socializzazione, abitua al rispetto delle regole e previene molte malattie dell’età adulta (ipertensione, ipercolesterolemia, malattie cardiache, obesità, diabete, alcuni tumori) oltre a permettere di sperimentare appieno i vari stimoli sensoriali e di acquisire autonomia, orientamento e identificazione con l’ambiente in cui il bambino vive. Un bambino attivo diventerà quasi sicuramente un adulto attivo e sano.
Le linee guida che seguono sono indirizzate ai genitori affinché preparino un ambiente funzionale a comportamenti corretti.
La prevenzione e la cura di ogni tipologia di eccesso di peso sono, in teoria, di facile attuazione. Se l’assunzione calorica dell’organismo è inferiore al dispendio energetico, il peso cala; in caso contrario, il peso aumenta. Facile in teoria, ma difficile in pratica, in parte per i seguenti motivi:
Nel corso dei millenni i geni umani hanno favorito gli individui che hanno immagazzinato grasso nei periodi di abbondanza per poter sopravvivere nei periodi di carestia. Nei paesi sviluppati, dove c’è abbondanza di merci e facile accesso alle materie prime, vi è un eccesso di alimenti ricchi e appetitosi (cambiamento delle abitudini alimentari).
Sempre più spesso oggi si verifica una scarsa propensione a consumare energia mentre vi è una grande attrazione per le attività ricreative sedentarie (cambiamento dello stile di vita).
Cosa fare?
L’obesità è un fenomeno di tipo multifattoriale, la prevenzione e terapia devono rispondere in maniera altrettanto multi-integrata e persistente in merito a tutti i fattori coinvolti. Ciò è ancora più vero nei casi di obesità nell’infanzia rispetto ai casi di presenza dello stesso fenomeno in età adulta.
Per quanto riguarda il bambino, alla fase iniziale l’inquadramento diagnostico e la conoscenza generale, fa seguito un percorso personalizzato. Esso mira a renderlo soggetto informato e protagonista di scelte di salute, che avranno valore sia per il suo presente sia per il suo futuro di adulto più sano e quindi più felice.
Gli obiettivi riguardano:
- un’ educazione al corretto stile di vita, con l’apprendimento di nozioni di base sul cibo, sul movimento, sulla modificazione di abitudini non corrette;
- la conoscenza del mondo interno del bambino e del suo rapporto con i contesti esterni in cui vive, quali la scuola,la famiglia, il gioco, lo sport;
- un’educazione alla conoscenza delle emozioni, con particolare attenzione alla sfera delle emozioni negative e/o di quelle interessate nel rapporto con il cibo e con il corpo del bambino.
Gli strumenti utilizzati sono:
- il colloquio clinico con uno o più professionisti (medico, psicoterapeuta, psicoeducatore);
- il diario di bordo: diario personale in cui il bambino trova riprotate delle semplici regole da imparare e del materiale da compilare giorno per giorno;
- il materiale didattico ed educativo: cd rom didattici, gioco interattivo, disegno, gioco esperienziale.
- i test proiettivi.
Tali strumenti variano e sono appositamente adeguati in base a due fasce d’età:
Dai 14 ai 18 anni, sussistendo già una buona capacità di autogestione e consapevolezza, di pensiero complesso e di autonomia, il protocollo applicato è simile a quello dell’adulto.
Per quanto riguarda la famiglia, è importante sottolineare come essa debba fungere non solo da accompagnatrice, ma piuttosto come coattivatore presente e ausilio fondamentale al bambino in questo percorso.
Ad essa è riservato uno spazio parallelo e separato dal figlio nelle visite, attraverso colloqui personalizzati (di coppia o con il singolo genitore) con un professionista diverso (dietista, medico, psicoterapeuta).
Le finalità del trattamento familiare in questo ambito riguardano:
- Informazioni mediche e dietologiche sullo stato del bambino;
- Educazione alimentare e corretta gestione del cibo in famiglia;
- Informazione costante su progressi, eventuali difficoltà e cambiamenti nel figlio;
- Supporto e a casa e verifica nel perseguire le indicazioni date a livello della gestione alimentare e motoria;
- Condivisione, sostegno e trattamento di eventuali difficoltà relazionali o emotive i famiglia che possano contribuire al problema o alterare un rapporto funzionale con il cibo.
Prenota la visita