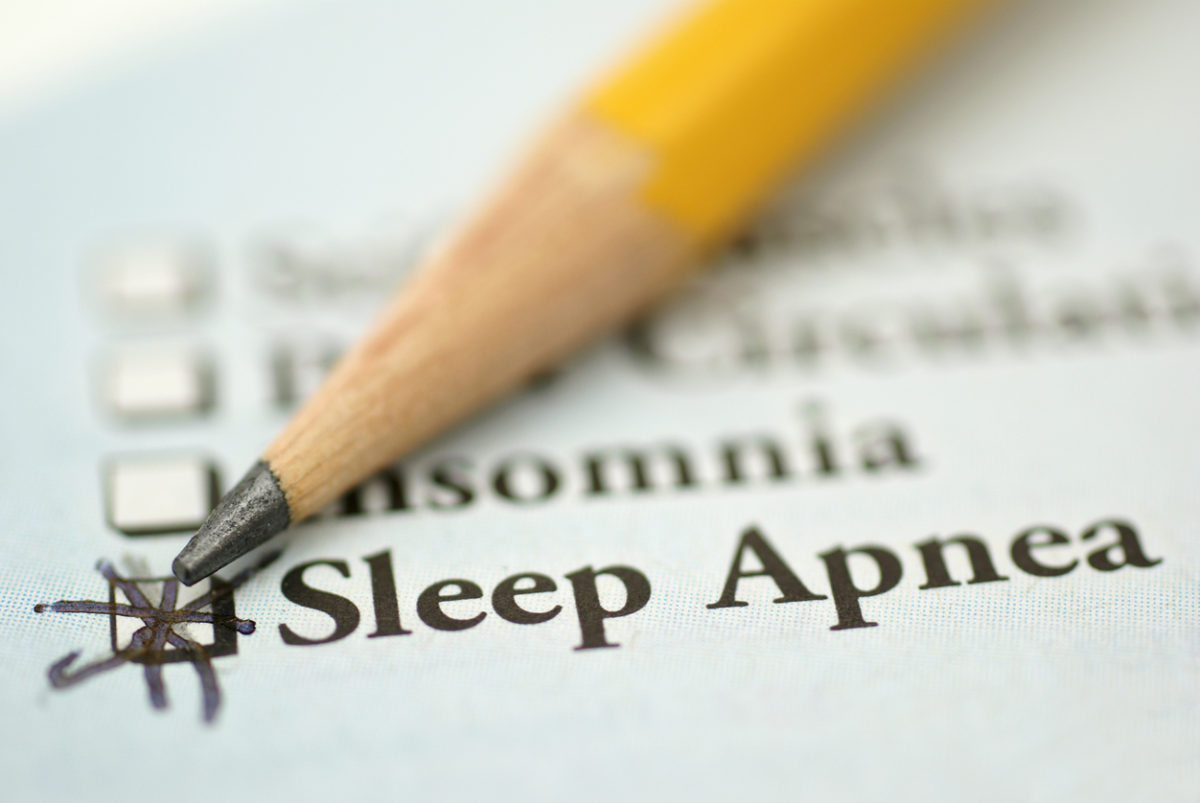Il bisogno maggiormente condiviso dal punto di vista psicologico e sociale da tutte le persone è il raggiungimento di uno stato di benessere globale, esteriore e interiore. Il sentirsi bene è un’esperienza interna, cognitiva ed emotiva, uno stato consapevole, un sentimento piacevole di contentezza e soddisfazione. Essa dipende da numerosi fattori, situazionali (esterni) o di personalità (interni): la realizzazione di sé, il successo personale, la possibilità di interazioni sociali, la cessazione di un problema, l’effettuazione di esperienze positive, l’essere ottimisti, l’avere un corpo che piace, non avere disagi. Ci sono vari elementi che non possiamo direttamente controllare, individuabili come fonte di benessere ma tanti altri invece possono essere personalmente ricercati e costruiti, per sentirci meglio con il nostro corpo, con la nostra persona e con gli altri, per rendere la vita più salutare, più piacevole e significativa.
Il benessere è una dimensione che può essere allenata.
Innanzitutto è fondamentale, a tal fine, partire dalla conoscenza di sé e di quello che si è, delle proprie caratteristiche, risorse e limiti.
Questo consentirà di poter rafforzare e intervenire da soli su se stessi per valutarsi, migliorarsi, per trovare la soluzione a un disagio, per adottare uno stile di vita più corretto, oppure permetterà di rendersi consapevoli delle aree in cui non si è capaci di attuare da soli un cambiamento e di chiedere aiuto ad uno specialista per essere accompagnati verso uno stato di maggior benessere.
Per chi desidera iniziare a prendere consapevolezza del proprio stato di benessere e fare qualche piccola ma utile cosa per incrementarlo, proponiamo alcuni consigli e linee guida. Provare ad applicarli gradualmente nella propria quotidianità consentirà di iniziare a migliorare qualcosa di sé o a trovare la strada per chiedere un sostegno per sentirsi meglio.
Riguardano tre dimensioni della persona:
Fare
Tenersi occupati in attività piacevoli, sociali, significative, fisiche
Soprattutto le attività piacevoli, nuove, che prevedono un contatto con gli altri, che facciano sentire efficienti e produttivi, che abbiano un importante significato per sé permettono di sentirsi più contenti e di avere energia, entusiasmo. È essenziale pertanto, anche la scelta di un tipo di lavoro che gratifichi o, laddove ciò non è possibile, lo svolgimento di attività utili e piacevoli durante il tempo libero.
Condurre uno stile di vita sano e dinamico
La ricerca dell’equilibrio giusto e della correttezza sul piano alimentare e motorio consentono di avere un giudizio più positivo di sé, di piacersi e piacere di più, di ricevere rinforzi positivi alla propria autostima. L’incremento dell’attività fi sica agisce contro la depressione, la noia, l’isolamento, oltre che sulla salute del fisico e sulla prevenzione di malattie. Attività che implicano sforzo fisico sembrano inoltre generare più piacere rispetto a delle attività sedentarie.
Organizzarsi e pianificare le proprie attività
È bene avere una buona capacità organizzativa generale sia nel quotidiano che nei progetti a lungo termine, essere efficienti e non rimandare, chiarificando i propri obiettivi e godendo dei risultati ogni giorno raggiunti.
Avere cura della propria salute psicofisica
Percepirsi e vedersi in modo più positivo fa vivere meglio e per sentirsi tali i primi passi sono l’attenzione e la cura all’alimentazione, allo stile di vita e all’esercizio fisico. Principi fondamentali per sentirsi bene sono anche ricercare la conoscenza di se stessi, perseguire la propria realizzazione, sapersi accettare, saper trovare un tempo da dedicarsi per attività ritenute rilassanti o piacevoli, saper riconoscere eventuali disagi, cercarne la soluzione o, qualora ci si renda conto di non potersela dare da soli, cercare un aiuto anche professionale. Possiamo immaginare la nostra mente e il nostro corpo come una pentola a pressione in cui, se continuiamo ad introdurre elementi sfavorevoli al nostro benessere e alla salute, senza dare possibilità di sfiato, il coperchio prima o poi scoppierà in un disturbo.
Essere
Essere se stessi.
Poiché tutte le persone sono differenti, è importante costruire e mantenere la propria identità, che poi potrà piacere ad alcune categorie di persone e non ad altre (questo vale per tutti qualunque identità si scelga di vestire) e non attuare caratteristiche e modi di essere che non sono propri, poiché l’ambiguità nel tempo emerge e diviene causa di conflitti e insoddisfazione.
Essere socievoli
L’uomo è per natura un essere sociale e pertanto necessita della relazione con altre persone significative da cui trarre e dare sostegno, crescita, rinforzi positivi e condivisione.
Essere orientati sul presente
Per stare bene non è utile orientare i propri pensieri per lo più altrove rispetto al momento che si sta vivendo: è invece importante saper investire nel qui ed ora, saper cogliere le opportunità che si presentano momento per momento, poter utilizzare la proprie energie psicofisiche per dare massimo valore a ciò che si può vivere giorno per giorno.
Essere ottimisti
Spesso il modo in cui si interpretano gli eventi ha molta più importanza degli eventi in sé. Chi riesce a trovare un senso valido ad un’esperienza negativa o chi sa giudicare in modo positivo un qualcosa che di per sé sarebbe neutrale o ambiguo, avrà più capacità nell’affrontare le difficoltà, più emozioni positive che consentiranno, a loro volta, il raggiungimento di obiettivi più positivi.
Sviluppare
Aspettative adeguate
Avere aspettative molto elevate ed essere perfezionisti spesso è causa di delusioni e insoddisfazioni, poiché non sempre e non per tutti è possibile raggiungere determinati traguardi e spesso lo sforzo richiesto è maggiore del piacere ottenuto. La modalità per sentirsi bene e felici è dunque riposta nella capacità di moderare le proprie aspirazioni in base alla realtà personale ed esterna e saper sfruttare e valorizzare il presente più che un risultato continuamente posposto e inarrivabile.
Rapporti sociali e intimi
L’attività sociale, essenziale per la sopravvivenza della persona, è fondamentale anche per il benessere mentale ed emotivo. È importante crearsi vari spazi di interazione sociale, di tipo sia formale che informale: essa consente di arricchire la propria personalità, di confrontarsi, di ricevere stimoli positivi, di rafforzare la propria identità. Soprattutto le relazioni profonde, intime, significative, risultano avere un’importanza fondamentale per il nostro benessere psicofisico.