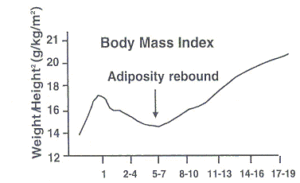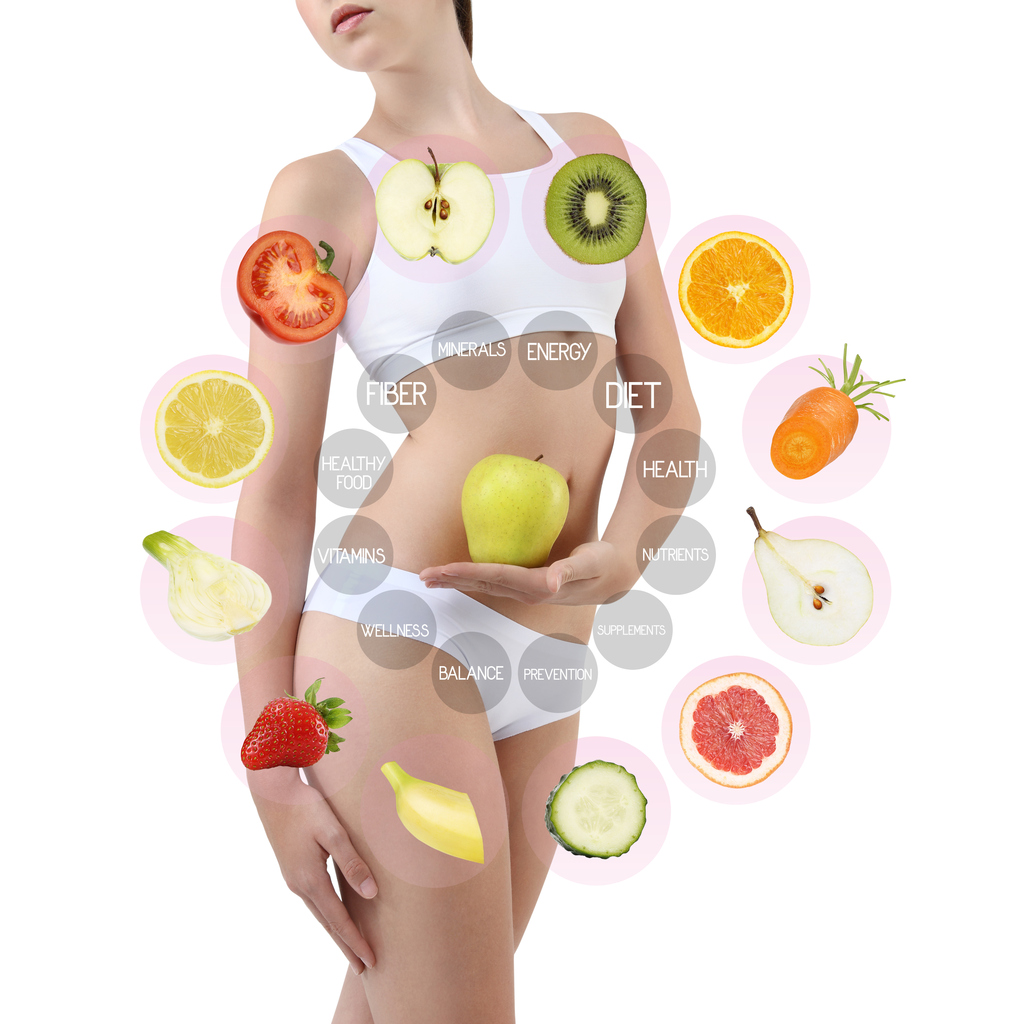Una prescrizione dietetica troppo rigida determina un adattamento metabolico ovvero un abbassamento del valore del dispendio energetico iniziale di un valore pari al 20-25%.
In questo modo si assiste ad una perdita di peso iniziale che si arresterà quando l’apporto calorico della dieta sarà pari al dispendio energetico del soggetto a riposo.
E’ la differenza tra ciò che si consuma e ciò che si introduce che ci permette di perdere peso.
La massa adiposa viene metabolizzata (bruciata) per sopperire le calorie in difetto.
Se si vuole evitare l’adattamento metabolico e avere una perdita di peso costante bisogna misurare il consumo energetico a riposo e l’apporto calorico della dieta non dovrà discostarsi dal valore misurato.
Interventi dietetici basati su calcoli teorici o peggio ancora volutamente forzati verso un livello di calorie molto basso (inferiore alle 1100 calorie) determineranno dei danni biologici importanti.
Schematicamente i danni da dieta rigida possono essere riassunti in quattro categorie:
- Adattamento metabolico
- Compromissione della composizione corporea
- Danni Psicologici
- Danni Comportamentali
- Adattamento metabolico
Come detto precedentemente, l’adattamento metabolico rappresenta la difesa dell’organismo all’improvvisa riduzione dell’introito calorico oponendosi in questo modo alla perdita di peso e favorendone un suo recupero immediato.
Il concetto di rigidità riferito ad una dieta è un valore assoluto quando si prescrivono diete forzatamente ipocaloriche (pari o inferiori a 1000 calorie) per il resto è un concetto relativo visto le differenti misure del dispendio energetico che si riscontrano nei vari soggetti.
Pertanto le 1500 calorie possono essere tante, poche o normali a seconda dei soggetti di riferimento.
Compromissione della composizione corporea
La perdita di peso, che spesso viene associata al dimagrimento, in realtà altro non è che perdita di massa corporea ovvero la perdita di tessuto adiposo, massa muscolare, massa cellulare, acqua.
Dimagrire in realtà dovrebbe significare divenire magri, quindi perdere grasso e non massa magra (muscolo, massa cellulare).
L’obiettivo della corretta nutrizione nel dimagrimento è quello di far coincidere la perdita di peso con la sola perdita di tessuto adiposo.
E’ nostra esperienza riscontrare come la perdita di peso superiore a 0,5 -1 Kg alla settimana difficilmente corrisponde alla perdita di solo tessuto adiposo, specie quando l’intervento dietetico è limitato nel tempo.
Nel lungo periodo, ossia quando l’intervento dietetico dura mesi, la corrispondenza tra perdita di peso e perdita di massa grassa è elevata.
Un intervento corretto, rapportato alle esigenze metaboliche misurate inizialmente e monitorate periodicamente, ci consente di modificare la composizione corporea a favore della massa magra (muscolare, cellulare).
La perdita di peso ottenuta con la sola prescrizione dietetica è seguita, in una percentuale altissima pari al 95%, da un recupero del peso superiore ai chili persi; cosicchè nel tempo, e dopo diversi interventi dietetici si pesa tanto più di prima. La percentuale di tessuto adiposo – che in un soggetto normale oscilla dal 15% al 30% – aumenta a parità di peso se l’individuo si è sottoposto a diversi regimi dimagranti.
Si comprende quindi il paradosso delle diete dimagranti che alla lunga sono “ingrassanti”. Se perdo e recupero dieci chili, perdo una percentuale di grasso che di certo è inferiore alla percentuale di grasso che accumulo nella fase di recupero del peso.
Danni comportamentali: perdita di controllo
La perdita di controllo ovvero l’incapacità di assumere la quantità di cibo desiderata e programmata è spesso preceduta da un periodo (ore o giorni) di marcata restrizione dell’apporto calorico.
La rigidità di una dieta deve essere definita relativamente al dispendio energetico del singolo individuo. E’ di certo rigida una dieta con apporto calorico inferiore alle 1000 calorie ma lo può essere anche la dieta di 1500 kcal o oltre se quel determinato individuo ha un dispendio energetico elevato.
Si impone, pertanto, la necessità della misurazione del dispendio energetico prima di impostare un regime alimentare, perché solo in questo modo si potrà essere certi che il dimagrimento non determinerà danni a carico del metabolismo, della composizione corporea e del comportamento alimentare.
La riduzione drastica dell’apporto calorico porta, in alcuni soggetti, alla perdita del controllo, all’iperalimentazione e al conseguente recupero del peso. L’intervento nutrizionale prescrittivo attuato con la calorimetria pertanto trova una sua collocazione ben precisa nell’intervento educazionale dell’obesità .
Visto che la calorimetria indiretta registra dispendi energetici a riposo superiori ai valori predetti in un numero elevato di soggetti con sovrappeso è possibile la prescrizione dietetica con apporto calorico alto.
Danni psicologici: i sensi di colpa
Il proposito di rispettare un piano prescritto seguito dall’incapacità di attuarlo porta nei soggetti obesi ad una disistima sempre maggiore che può sfociare in pensieri fallimentari depressivi che rischiano di compromettere la qualità della vita.
Nei soggetti obesi o sovrappeso, con alle spalle una lunga storia di perdita e recupero del peso, è di frequente riscontro, o meglio è quasi sempre presente, il circolo vizioso dei sensi di colpa.
La dieta rigida intesa come prescrizione, ma principalmente come messaqgio o proposito dimagrante senza possibilità di trasgressione, porta allo sviluppo di pensieri e comportamenti che perpetuano l’obesita. Un’obesita con disturbo del comportamento alimentare.
La dieta rigida prima o poi è seguita dalla perdita di controllo che porta ad un’assunzione di cibo per quantità e modalità diversa dai soggetti normopeso.
L’abbuffata è seguita dai sensi di colpa e da una situazione fallimentare depressiva. Questa mette in atto quei meccanismi emotivi e metabolici che portano a consolarsi con altro cibo in attesa di avere un’altra volta la voglia di ricominciare o di sperimentare qualcosa di nuovo.
La persistenza di tale stato fallimentare depressivo e lo sperimentare il peso dei sensi di colpa, che pesano di più dei chili stessi, innesca dei meccanismi differenti nei vari soggetti.
I soggetti giovani, con una forte motivazione estetica associata ad un insoddisfazione corporea marcata, possono arrivare al vomito -tecnica dimagrante semplice ed economica- o al rifiuto di cibo: nel primo caso per liberarsi dai sensi di colpa e dal cibo stesso, nell’altro per non sperimentare ancora i sensi di colpa. Si capisce come le due situazioni rappresentino l’anticamera di anoressia e bulimia.
Un terzo gruppo di soggetti -meno giovani e con più fallimenti alle spalle- decide di accettare l’obesità stessa vista l’incapacità di non riuscire nell’intento dimagrante;
accettazione apparente ma obbligata e in grado di far stare meno male rispetto ai sensi di colpa di cui si è stati più volte vittima.